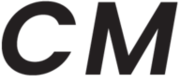DI Marco Torcasio - foto di Andrea Rossetti
21 March 2022

La relazione con Raymond Depardon nutre la nostra programmazione sia quando è lui a farne parte sia quando è lui a ispirarla. I temi che tocca, l’inclusione, il nesso tra artista e soggetto, il potere dell’immagine, possono invadere territori artistici diversi, ma la sua azione va al di là dei numerosi progetti. È sempre Depardon a offrirci la sua opera, non il contrario.
La vita moderna è stata concepita da zero per il pubblico milanese e per gli spazi di Triennale Milano. Troviamo una serie italiana sia in apertura che in chiusura, entrambe esistevano già nella sua opera, ma Depardon con questa scelta ha voluto di- mostrare quanto l’Italia sia stata presente nel suo lavoro, nella sua vita e nei suoi viaggi. La scansione della mostra mette in evidenza opere di piccole e grandi dimensioni, in bianco e nero o a colori, piene di gente o totalmente deserte. Per un totale di otto serie allestite senza alcun carattere retrospettivo, ma secondo un criterio concettuale molto forte.
Possono esserci molteplici modi di sentire e il mio non è certamente quello dell’artista, ma posso dire che il metodo prescelto per questa serie è scaturito da un suo stato d’animo. Depardon giunse a New York senza uno scopo preciso e, nonostante fosse già a abituato a viaggiare per il mondo, dal deserto all’America del Sud, visse quel soggiorno con disagio.
Decise di camminare per tutto il giorno, con la Leica al collo, imponendosi la regola di non sollevarla verso il viso, lasciandola appesa sul petto e riservandosi così la sorpresa di un’inquadratura volutamente non ricercata. La tecnica conferisce alla composizione un aspetto talvolta caotico, che riflette la frenesia e il movimento perpetuo della megalopoli che il fotografo conosce bene, di cui apprezza la naturale fotogenia, ma in cui si sente isolato. La serie, atipica nell’opera di Depardon, spiega benissimo questa assenza di empatia tra i soggetti e il fotografo.
Alla fine degli anni Settanta, Raymond Depardon intraprese un viaggio alla scoperta della realtà degli ospedali psichiatrici di Trieste, Napoli, Arezzo e dell’isola di San Clemente, a Venezia. In questa occasione incontrò Franco Basaglia, stabilendo un rapporto di fiducia e collaborazione. Fu proprio Basaglia a incoraggiarlo a concepire quella che oggi è annoverata tra le testimonianze più commoventi sulla vita nei manicomi alla vigilia dell’adozione della Legge del 1978, destinata a rivoluzionare il sistema ospedaliero psichiatrico italiano.
Intervista a Grazia Quaroni pubblicata su Club Milano 62. Clicca qui per sfogliare il magazine.